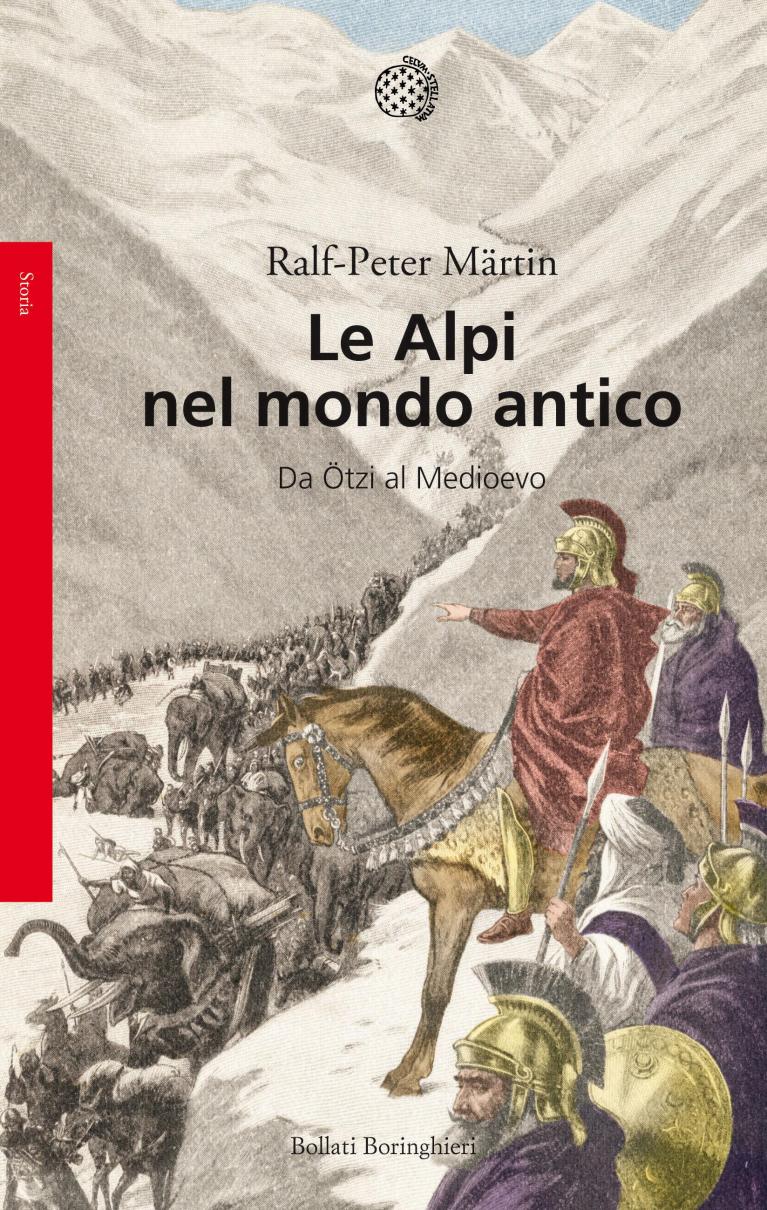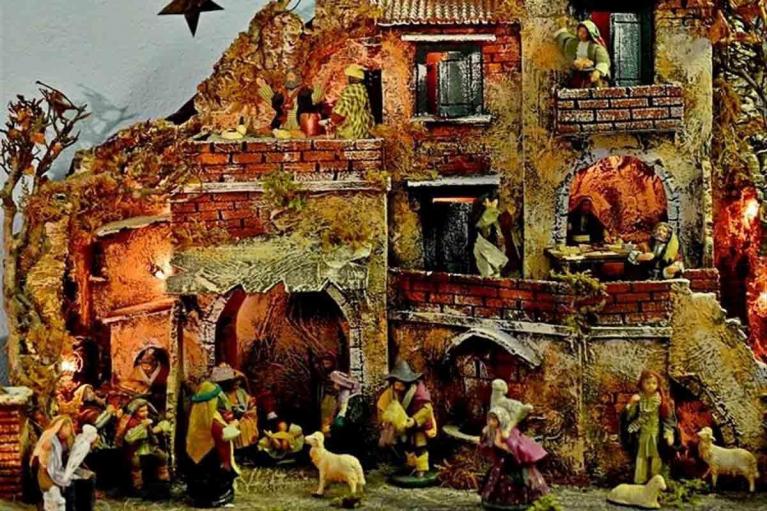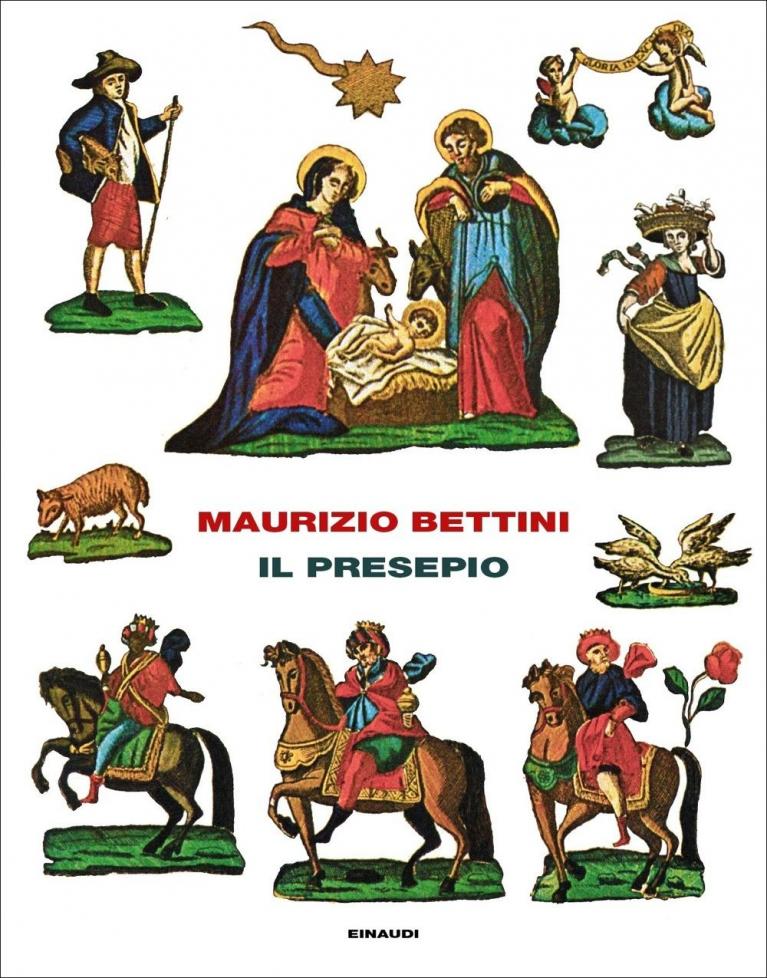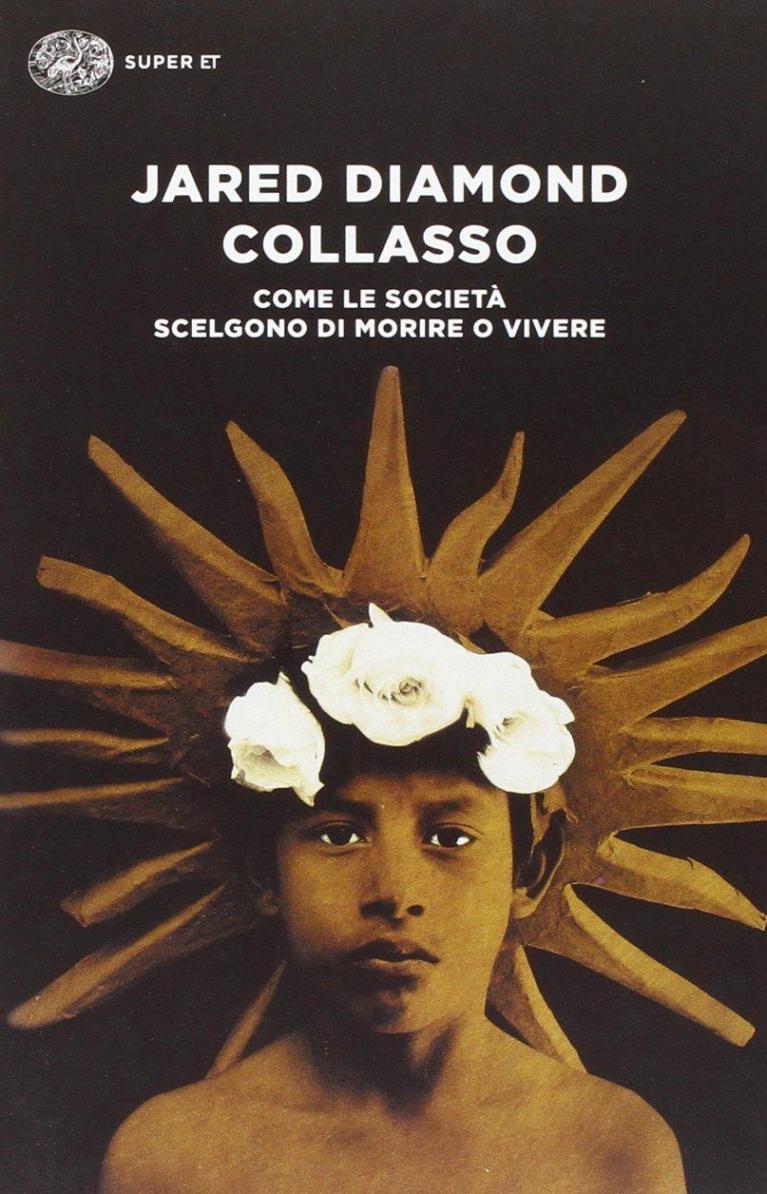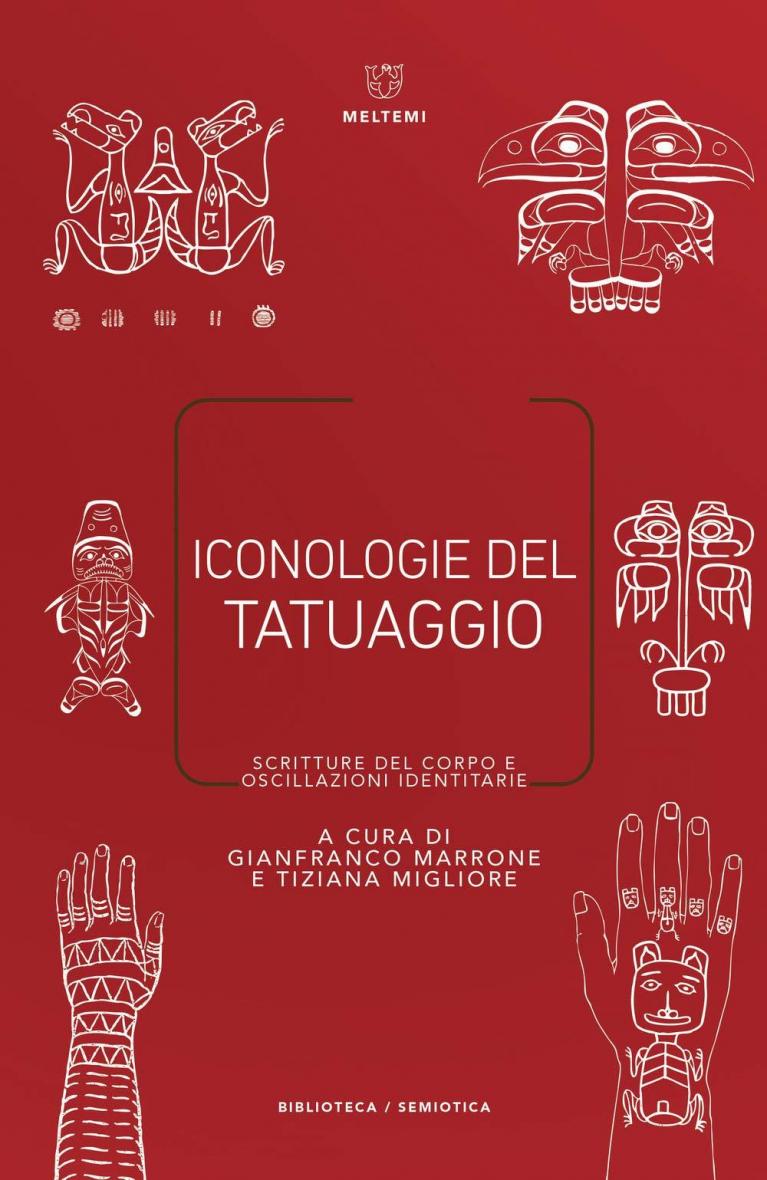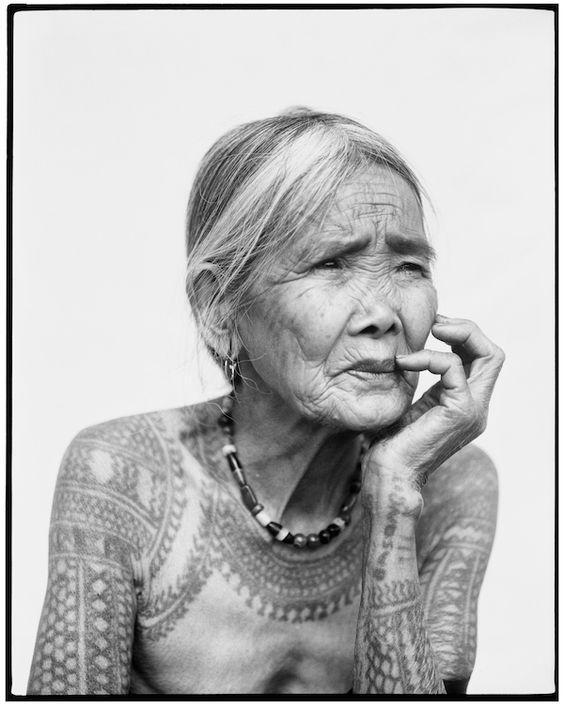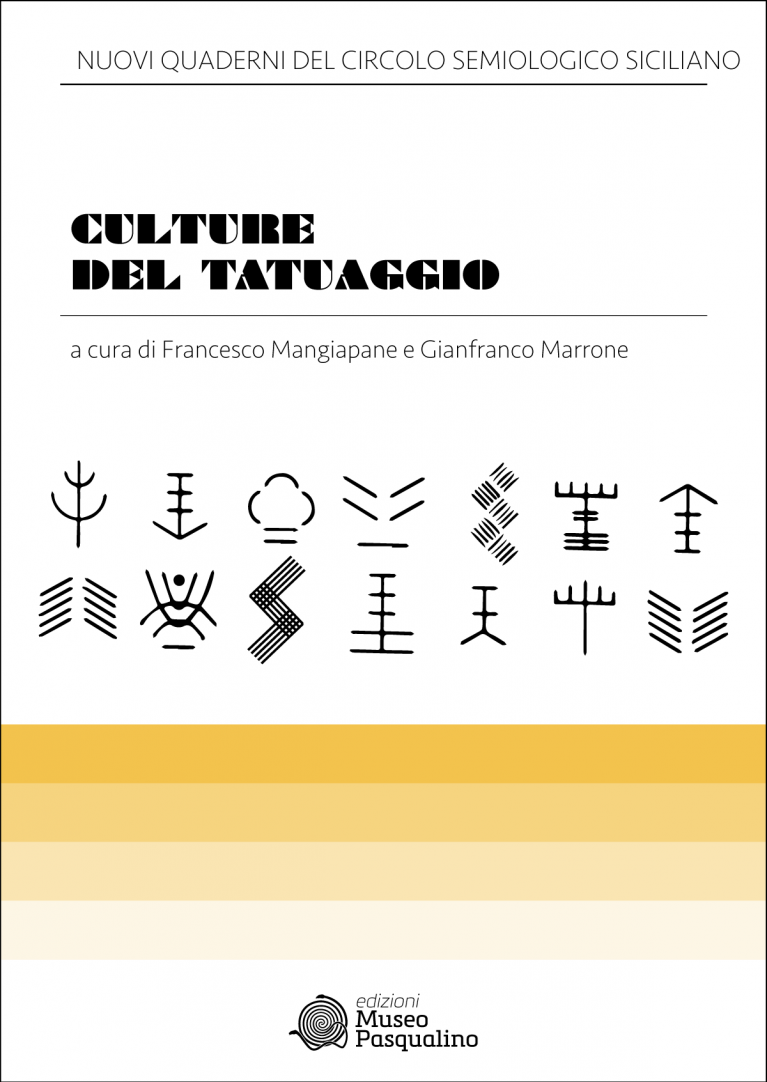La “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” fu proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunita a Parigi, Palais de Chaillot, il 10-12-1948 da 48 Stati usciti vincitori dalla guerra, nello stesso anno della nostra costituzione repubblicana.
La discussione non fu facile. Si accesero discussioni sulle priorità dei principi, quali potevano essere dichiarati “inalienabili” o “universali” o “fondamentali”, se era necessario prospettare un loro fondamento teorico. Nacque il testo che si sviluppò in 30 articoli che delinearono diritti e principi, senza forza di legge ma di monito influente sul loro rispetto.
E poi si infittirono studi, approfondimenti che condussero ai Patti internazionali del 1976, strutturati in due articolati, quelli sui “diritti economici, sociali e culturali” e quelli sui “diritti civili e politici”. La Commissione dell’Assemblea Generale lavorò lungamente, e il 16-12-1966 adottò i Patti, ma dovette trascorrere ancora un decennio prima che essi venissero ratificati da un numero sufficiente di stati per la loro entrata in vigore. In effetti occorreva per la loro adesione o ratifica il voto adesivo di almeno 35 stati. E questo avvenne nel 1976. Ogni paese che abbia ratificato il Patto si impegna a far sì che i suoi cittadini siano protetti e garantiti in quei diritti. Tali Patti stabiliscono l'obbligo per gli Stati che li abbiano ratificati a riconoscere attraverso obblighi giuridici quanto presente nella Dichiarazione. Si trattava di costruire un insieme coerente di principi giuridici fondamentali che si applicano in tutto il mondo sia agli individui che ai popoli.
Una prima domanda da porsi è perché quella Dichiarazione nasce nel 1948. La risposta è rintracciabile nel momento storico, ben sintetizzato nel Preambolo che prende atto, in via preliminare, del "disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani che hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità".
Cruciale e determinante era la necessità, alla fine della guerra con il suggello delle atomiche, di proteggere gli uomini per evitare il ripetersi di eventi distruttivi mentre già all'orizzonte comparivano le avvisaglie della guerra fredda. La memoria riandava al dramma della seconda guerra mondiale, allo Shoah, a regimi totalitari come fascismo e nazismo, alla presenza permanente di regimi repressivi. Con la metà del novecento la collettività sentì il bisogno di darsi regole e valori condivisi per delineare le basi su cui fondare un futuro di pace e sviluppo.
Quindi le carte e le organizzazioni sono un prodotto storico e costituiscono una svolta per cogliere lo spirito dei nuovi tempi. La Dichiarazione in particolare riesce a fungere da detonatore di valori e di altre prese di posizione. Nasce con il 1948 una maggiore sensibilità per la tutela dei diritti umani, anche se troppo spesso tenuti come alibi per giustificare provvedimenti a loro contrari, come ad esempio interventi di guerra in varie parti del mondo o atteggiamenti di tolleranza verso regimi che non li rispettavano.
La specializzazione. Nel frattempo e successivamente si sviluppa la "specializzazione", cioè l'attenzione rivolta a una determinata tematica dei diritti dell'uomo (qui ricordiamo, ad esempio, l'Accordo per la lotta al reato di apartheid del 1975, l'Accordo per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1980, la Convenzione sulla tortura e ogni altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante del 1984, l'Eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965, la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 1989, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti del migranti lavoratori, 1990, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone disabili, 2006).
Nel contempo le Carte estendono i confini geografici. La Carta Africana sui diritti umani e dei popoli è stata adottata a Nairobi nel 1981 ed è entrata in vigore nel 1986. Essa introduce il concetto dei doveri degli individui nei confronti della famiglia, della comunità, dello stato. I poteri di controllo sono vaghi e non è presente alcuna corte di giustizia.
Nel 1994 la Lega araba (organismo non religioso ma politico) ha adottato il testo di una "Carta araba dei diritti dell'uomo", nel cui preambolo si richiama la Dichiarazione Universale. Riconosce però soltanto l'eguaglianza delle opportunità, un salario equo e una remunerazione eguale a parità di lavoro, ammettendo così implicitamente una discriminazione fondata sulla nazionalità. È assente qualunque riferimento alla legge coranica, mentre ci si appella solo ai principi eterni definiti dal diritto musulmano, accomunandoli con quelli delle altre religioni. Nonostante le buone intenzioni anche questa Carta, come altre, non è entrata in vigore.
Il fenomeno della specificazione dei diritti è sicuramente da porsi in relazione al crescente numero di condizioni considerate meritevoli di tutela giuridica e all´allargamento della titolarità di alcuni diritti tipici a soggetti diversi dall´uomo. Nel contempo si afferma oggi l´impossibilità di considerare l´individuo come entità generica o soggetto astratto, e quindi si guarda alla specificità e alla concretezza delle diverse modalità dell´essere e dello stare in società. La manifestazione più concreta della moltiplicazione dei diritti per specificazione è data dal proliferare in ambito internazionalistico di una serie di strumenti giuridici rivolti alla tutela di soggetti diversi.
![Myriam Meloni]() Myriam Meloni
Myriam Meloni
Particolarmente significativa è stata la produzione internazionale normativa rivolta alle donne. Le Nazioni Unite hanno infatti riservato negli ultimi decenni alle donne un numero consistente di raccomandazioni, di dichiarazioni e di convenzioni settoriali, tanto che si può far riferimento a un corpus unitario di norme costituenti un codice vero e proprio. L´assunto fondamentale muove dal riconoscimento che la condizione femminile, date anche le diverse distinzioni, presenta caratteri universalizzanti. Le donne subiscono discriminazioni e violenze con modalità che spesso non toccano gli uomini poiché in larga misura i soprusi di cui sono vittime sono di natura sessuale e riproduttiva. Questi abusi si presentano in forme, modi e circostanze che, pur rientrando in qualsiasi convenzione ufficiale sui diritti umani, non hanno trovato appropriata considerazione a livello internazionale solo raramente, anzitutto perché commessi proprio a danno delle donne. Vi è da dire peraltro che più numerose sono le violazioni a carico di un gruppo sociale come sono le donne, paradossalmente meno facile è perseguire sul piano penale certe condotte, poiché taluni comportamenti vengono diffusamente percepiti e si configurano come elementi della normalità.
La convergenza e il compromesso La Dichiarazione Universale è il risultato della convergenza di più traiettorie intellettuali e costituisce il punto di raccordo di concezioni diverse dell´uomo e della società. Seguendo la scia di precedenti pronunce generali, è costituita da norme consuetudinarie che rappresentano valori fondamentali per la comunità internazionale e senza distinzione o, come si usa dire ora, senza se e senza ma. Sono la "dignità" protetta senza distinzione di differenze di religione, etnia, sesso; la "libertà" in relazione ai diritti legati alla libertà individuale ed alla sicurezza personale; l’"eguaglianza" che garantisce la partecipazione politica e pubblica di tutti e la "fratellanza" che si riferisce ai diritti economici, sociali e culturali.
Diffondere ed educare ai diritti umani significa favorire lo sviluppo armonioso della personalità dei singoli individui, riconosciuti all'uomo per la sua appartenenza al genere umano.
La continuità storica e l'innesto nella tradizione Come già sottolineato la Dichiarazione del 1948 non è spuntata per germinazione spontanea ma si è inserita nel solco della tradizione e rappresenta una continuità storica con il passato, anche se ciascun paese cerca collegamenti con la sua storia antica, con le origini lontane che fanno parte della sua cultura. Non esiste un concetto generale che ricomprenda tutte le diverse culture e società: l´espressione ‘diritti umani “riflette in realtà le diverse tappe segnate dall´evoluzione del pensiero, segnate da idee e concetti che li hanno forgiati e veicolati. Esso descrive l’esigenza di proteggere la persona umana mediante una barriera giuridica innervata da valori e prescrizioni legali, anche se la sua gestione è affidata agli stati i quali perseguono, per inclinazione costatata nel tempo, disegni alimentati dal proprio interesse e da desideri nazionali.
Il concetto “diritti umani” ha avuto una sua precisa evoluzione attraverso tre prospettive: quella occidentale, quella socialista e quella dei paesi del Terzo Mondo.
La concezione occidentale afferma che i diritti e le libertà emergono al di sopra dello stato e al di sopra delle organizzazioni politiche. Essi si rivolgono all´essere umano che è soggetto di diritto internazionale, e non sono la conseguenza di essere cittadino di uno stato. Negli ultimi 30 anni la concezione si è evoluta passando ad una concezione che riconosce non solo i diritti civili e politici ma anche l´effettività dei diritti economici, culturali e sociali, ritenendo che senza di loro quei diritti civili sono sforniti di una base materiale e rimangono formula vuota.
La concezione socialista si presenta con un approccio diverso sui diritti umani rispetto alla concezione occidentale: non accetta l´origine di diritto naturale quale diritto dei cittadini, non accetta l´ idea che il diritto dei cittadini rifletta la relazione tra l´ uomo e la società. La base è la società organizzata in uno stato e tali diritti dovrebbero esprimere la relazione tra lo stato e i cittadini. Lo stato rappresenta gli interessi dei cittadini e i cittadini non possono avere diritti in contrasto con quelli dello stato. E tale ruolo primario assegnato allo stato impedisce che vi possa essere qualsiasi forma di controllo internazionale. L´individuo si deve comportare secondo ciò che lo stato gli prescrive, perché tale comportamento corrisponde all´ interesse della società.
La visione del Terzo Mondo presenta difficoltà d´analisi poiché sono compresenti diverse culture, diverse forme di colonizzazione che hanno influito sulla formazione della comunità moderna. Non vi è un concetto comune sui diritti umani ma l´uniformità di condizioni, quali il sottosviluppo, la situazione politica ed economica, permettono una certa uniformità d´approccio al tema dei diritti umani. La realtà sociale ed economica del Terzo Mondo assegna maggior importanza ai diritti economici sociali e culturali e l´idea dello sviluppo economico ha la priorità rispetto alla garanzia dei diritti civili e politici. La maggioranza dei paesi del Terzo Mondo afferma che il risolvere i problemi riguardanti la malnutrizione, la povertà e l´educazione ha la priorità rispetto all´ affermazione dei diritti formali, i quali sono poco noti e non riscuotono interesse nelle masse affamate e ignoranti.
I "Diritti umani", come esposto, si sono nel tempo e nei secoli moltiplicati e specializzati, la loro Dichiarazione è lo sbocco di un'occasione storica e nel contempo nella tradizione storica si innestano e trovano alimento.
Essi sono universali secondo la Dichiarazione del 1948, ma in che modo? E in quale rapporto si pongono con la globalizzazione e il multiculturalismo? Come vi può essere nella società contemporanea qualcosa di valido per tutti, qualcosa in cui tutti si riconoscano senza sentirsi sradicati dalle rispettive appartenenze? Come può essere calibrato l'orientamento, espresso nella Commissione incaricata di redigere la Dichiarazione, secondo cui "il valore del testo si estende oltre la tradizione occidentale e la tutela di quei diritti deve essere riconosciuta a prescindere dal contesto in cui ci si trovi"?
Ampio è l'orizzonte entro cui si muovono e agiscono fenomeni la cui portata è appunto "mondiale", forse in termini riduttivi indicato come "internazionale". Dentro questo scenario si sono presentati almeno alcuni attori mondiali, e tra questi la globalizzazione e il multi-culturalismo che costituiscono l'orizzonte di vita degli uomini del terzo millennio.
La globalizzazione ha una pluralità di volti.
Uno di questi è quello tecnologico sociale. Cambia il rapporto della natura umana con lo spazio e con il tempo. L'individuo viene de-localizzato e proiettato in un universo sempre più grande, sempre più cosmico, nel quale perdono progressivamente significato le tradizioni, le consuetudini, le pratiche locali, i rapporti faccia a faccia. Il concetto stesso di "prossimo" svanisce per cedere a rapporti sempre più "virtuali". Questo processo di "dis-appartenenza", proiettata verso una società globale, si offre come un sostegno per i diritti umani che in origine non sono forse stati diritti dell'uomo astratto, a prescindere da ogni differenza.
![]()
La globalizzazione ha anche oggi un volto propriamente politico. Questa concezione dell´universalismo si è sviluppata dal crollo dell´ Unione Sovietica, dalla fine della contrapposizione dei blocchi Occidente e Oriente consentendo ai diritti umani di porsi in una visione universale.
È nota la robusta obiezione all'universalismo dei diritti.
I diritti umani che si intendono tutelare provengono dalla nostra cultura cioè dalla cultura occidentale, liberal-democratica, di matrice cristiana, e questo è stata interpretata da taluno come espressione di una prevaricazione culturale. Il concetto di diritti umani rinvierebbe alla nostra immagine del diritto, formata in Europa e in America in un’epoca nella quale esse pretendevano di imporre la loro misura a tutto il resto del mondo. Quel paradigma che chiamiamo universale urterebbe con il rispetto dovuto a soggetti e culture diverse dalla nostra, cui noi pretenderemmo di imporlo. E correlativamente la validità dei diritti fondamentali presupporrebbe un qualche grado di consenso sociale che in sostanza può esistere soltanto nel sentirsi appartenenti ai nostri ordinamenti occidentali e non invece in culture diverse dalla nostra.
In effetti l’Occidente ha preso, seppur stentatamente, la consapevolezza della irriducibile pluralità delle culture, nonché della debolezza di quell'orientamento che pretende di assolutizzare i propri valori culturali e far assumere la propria cultura ad unità di misura di ogni altra.
C’è da sottolineare, però, che i diritti umani nella loro dimensione universale non contraddicono la pluralità delle culture ma rappresentano sotto molti aspetti la traduzione, perfettibile ma irrinunciabile, dei linguaggi nella odierna società globale come è stato osservato (F. Viola, Etica dei diritti umani, Giappichelli, Torino, 2000). Ciò significa non già tradire l'essere connessi a una tradizione particolare, quella occidentale, ma essere consapevoli di questo non tradisce il paradigma della loro universalità.
Né è riscontrabile un limite nella supposta l’incapacità di varcare i confini dello specifico contesto culturale e dell’esperienza giuridica dell’Occidente. Il dialogo tra culture differenti è in effetti arduo, sembra un linguaggio tra tribù come acutamente notato (T. Todorov, Noi e gli altri, Einaudi, Torino, 2011), L’elemento universalistico non va cercato però nei "fondamenti" dei diritti, ma nella "globalità" dei titolari di quel diritto, riconoscendo nel linguaggio dei diritti il “gesto di affermare la propria dignità”.
L'apprezzamento della validità di ciascuna cultura potrebbe condurre però ad una sorta di relativismo culturale. Secondo questo orientamento non esiste una natura umana o essere umano ma solo esseri culturali, non esiste un orizzonte transculturale che comprenda le pratiche sociali diffuse nelle diverse società, non vi è possibilità di dialogo tra culture in quanto ogni cultura, nella sua incommensurabilità, può essere compresa solo assumendo un punto di vista completamente interno. Quindi non si tratta, secondo questo modello, di sottolineare la diversità e spesso la difficile comunicabilità tra culture diverse, ma sostenere che le culture sono autosignificanti, universi chiusi che non rinviano ad altro che a se stessi.
Orbene questa impostazione è stata censurata sotto vari aspetti (tra i tanti L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, Laterza, Bari, 2001).
Un primo limite di questo approccio è l'assegnare in vario modo uguale valore a tutte le culture, persone, etiche. Si tratta di un pericoloso indifferentismo che porta alla dissoluzione delle strutture etiche, è il pendant morale del relativismo culturale, in quanto ha come esito l’accettazione di qualunque cultura e l'annullamento del valore di tutte le culture, nonché la loro separazione e segregazione come culture antagoniste e non comunicanti.
Va evidenziato al proposito che l’universalismo è anche una prerogativa non dei soli sostenitori dei diritti umani, ma anche di coloro che ritengono “giusto” lasciare che ogni cultura disciplini i comportamenti degli individui che ne fanno parte (stabilendo, ad esempio, lo sgozzamento dei nemici, la lapidazione delle adultere, pene corporali per alcuni reati, la distinzione in caste, ecc.). Si tratta di un approccio relativista che, in effetti, adotta una posizione universalista in quanto attribuisce lo stesso valore a tutte le culture, invece che a tutti gli individui. Il caso delle donne nei paesi che limitano i loro diritti è esemplare. Adottare il modello relativista significa non interferire su quei costumi e quindi consentire implicitamente il perpetuarsi delle compromissioni dei diritti.
Sotto un profilo più giuridico, l'universalismo dei diritti e quindi come categoria giuridica si pone come nozione differente dall'universalismo come dottrina morale.
Sono entità che si assestano su piani non incrociabili, e l’universalismo dei diritti non può condurre alla condivisione morale di quei principi. La convenzione dei diritti non richiede l'accettazione morale neppure della maggioranza dei soggetti entro cui è maturata e del resto le libertà sono nate come rispetto delle culture degli altri, non come prodotto della maggioranza.
Se fosse vero il contrario alcuni scritti, come quello di Verri o Beccaria, sarebbero rimasti in un angolo, isolati e impolverati.
Lo statuto costituzionale di diritti ha una componente garantista secondo cui non è richiesta l’adesione ai valori etico-politici ad essa sottesi. Sono i valori che derivano dai diritti a “imporre di non imporre” ad alcun tipo di etica o credo politico di appoggiare uno Stato "etico". Naturalmente si richiede una qualche adesione sociale per rendere effettivi i diritti umani, che altro non sono che significati normativi la cui tenuta dipende sempre da un certo grado di consenso ai valori sottostanti. Tuttavia il formarsi di questo comune senso civico è da conquistare con mezzi di tipo culturale e politico e non deve essere imposto con il diritto, che invece esige la tolleranza di tutte le identità politiche.
Lo stato di diritto non può essere confuso con la democrazia politica basata sulla maggioranza. Paradossalmente i diritti fondamentali sono contro la maggioranza perché rappresentano il limite ai poteri. Questa è la garanzia: si sottrae il diritto fondamentale alla politica, al potere delle contingenze proprio perché inalienabile inviolabile e indisponibile. Il fondamento democratico del patto costituzionale sui diritti fondamentali è che sia siglata la non esclusione di nessuno.
Infine, ma non alla fine, questo è il confine tra rispetto delle altre culture e il rispetto dovuto agli individui in forza del patto fondamentale. L'obiettivo riguarda gli individui e non le culture. I diritti fondamentali, strutturalmente individuali e non collettivi, sono da sempre la legge del più debole rispetto a quella del più forte, può essere la legge delle proprie culture che tutela l’individuo contro il suo stesso ambiente culturale e familiare, la donna contro il padre o il marito, il minore verso i genitori, gli oppressi contro gli oppressori.
Sarebbe un segno di eurocentrismo non già esclusivamente affermarli ma negarli in danno di quanti appartengono a popoli e culture che non hanno avuto il nostro percorso storico. Proprio il principio di tolleranza tutela delle libertà e rispetta le differenze garantendo eguale diritto alle differenze che rendono ogni individuo diverso dagli altri. L’universalismo dei diritti fondamentali è la garanzia del pluralismo culturale, della convivenza e del rispetto delle differenze.
Del resto esiste un'abissale differenza tra relatività delle culture (per cui ciò che è relativo nei modi di una certa cultura è la traduzione di valori e princìpi che mantengono una cogenza definita) e relativismo culturale (che nega, in nome della pluralità delle culture, l’esistenza di valori che attraversano o stanno alla base delle varie culture e che così conduce all’impossibilità del dialogo culturale).
Riassumendo, il senso dell'universalismo è considerare il particolare come parte di un tutto. I tratti comuni sono sempre incastonati all'interno di particolari sistemi culturali, e sono elaborati in modi specifici. L’universalità è un principio regolatore che consente il confronto delle differenze, e il suo contenuto non può essere stabilito una volta per sempre, ma è sempre soggetto a revisione. Comunque il riferimento richiama l’appartenenza alla collettività umana, talché le differenziazioni culturali in cui si articola l’umanità risultano legittime nella misura in cui si armonizzano con l'appartenenza comune.
L’umanità in realtà esiste al plurale, la sua condizione è la diversità. Noi esistiamo diversi, ma siamo chiamati al compito della comunicazione e dell’incontro con l’alterità affinché l’azione umana possa continuare.
Se si ammette che le culture particolari possano comunicare, si deve allora ammettere un disegno universale, rintracciabile nell’unità antropologica dell’esperienza, un terreno comune su cui è possibile ritrovare un senso reciproco legato alla loro sottostante valenza unitaria. Ciò, tra l’altro, rende possibile la "comprensione", che consiste nel vedere connessioni e comporta l’esistenza di un orizzonte comune che connette le parti. L’universalità è l’esito di un processo che si compie per tentativi, nell’orizzonte della comune condizione esistenziale. E quindi occorre riconoscere che vi sia un senso riguardo alla vita umana e che possa essere ricercato proprio a partire dal riconoscimento della nostra comune condizione. L’ascrizione universale di diritti è una spettanza irrinunciabile dell’individuo come fine in sé. In questo spazio, che è quello della dignità umana, fanno senso le differenze e le diversità.
Questo percorso è collegato al riconoscimento della condizione umana legato all'esperienza, al “poter essere” che si attua in una dimensione pratica e proiettata nel futuro. In realtà la progettualità è la struttura che innerva l'esistenza umana, si realizza nei rapporti tra soggetti, come il linguaggio che consente di acquistare conoscenza e familiarità del mondo e di apportare esperienza. Sono le reti di comunicazione che, tanto più oggi, interagiscono nella comunità e costruiscono la possibilità dell'agire. È la persona nel suo essere parlante ed agente, che realizza il suo essere. Questo potere su altri offre anche occasioni per infliggere danni e per imporre sofferenze. Un soggetto, esercitando un potere su un altro, tratta quest’ultimo come il “paziente” della sua azione. La maggior parte delle sofferenze “sono inflitte all’uomo dall’uomo. Esse fanno sì che la parte più importante del male nel mondo risulti dalla violenza esercitata tra gli uomini... La vittimizzazione appare allora come il rovescio di passività che funesta la gloria dell’azione”, come osserva P. Ricoeur (La persona, Morcelliana, Brescia, 1997).
Il tema sociale della sofferenza si lega a quello della dignità. Diventa rilevante, sotto questo aspetto, che le persone abbiano assicurate le condizioni affinché la loro vita venga considerata e sentita come una vita che valga la pena di essere vissuta, attraverso l’eliminazione della sofferenza socialmente generata.
Si staglia così la nozione di “soggetto capace”, che rinvia alle dimensioni della stima e del rispetto di sé e si colloca nelle intersezioni delle azioni sociali.
L’individuo, infatti, per realizzarsi ha bisogno di mediazioni interpersonali e istituzionali e senza le quali le capacità resterebbero sulla carta. Proprio nel minimizzare la sofferenza evitabile, nel proteggersi dal veder incrinato lo status di soggetto agente, trovano giustificazione quei diritti di cui è titolare ogni essere umano in quanto tale. Questi compone il disegno di “universali esistenziali” che strutturano la maniera propria di esistere, di essere al mondo, di quell’essere che ciascuno di noi è, e rende possibile parlare in maniera universale dell’essere umano in situazioni culturali variabili.
Il contenuto dell’universalità, così, non potrà essere identificato stabilmente e per sempre. In questo ambito va ricercato l’equilibrio tra l’istanza universalistica dei diritti e le loro reinterpretazioni “locali”.
Integrare l’indigenza, ridurre la sofferenza, evitare l'erosione delle basi della dignità e dell’eguale rispetto, e agire perseguendo i propri progetti di vita nello spazio della vita in comune, richiedono che siano soddisfatte alcune esigenze basilari. Si tratta di condizioni necessarie per mantenere una persona al livello minimo di possibilità di condurre un’esistenza non umiliante e non degradante, di realizzare i fini prescelti, e di compiere azioni, di svolgere le proprie capacità di vita, di sviluppare la propria individualità, in condizioni di parità con gli altri.
I diritti umani sono decisivi perché proteggono la capacità di azione degli individui, cioè la capacità di perseguire obiettivi senza ostacoli o intralci. L’attenzione si dirige a ciò che i diritti fanno per gli esseri umani. La protezione della capacità di azione di ogni essere umano rappresenta il loro scopo essenziale, come osservato da un attento studioso (M. Ignatieff, Una ragionevole apologia dei diritti umani, Feltrinelli, Milano, 2003).
Al di fuori di ogni idolatria i diritti sono “una cassetta degli attrezzi” a disposizione degli esseri umani per conferire potere e voce a chi potere e voce non ha, esprimono il linguaggio mediante il quale si difende l’autonomia degli individui. Contribuiscono a comporre i requisiti di vita decente senza violare le identità culturali che popolano il mondo. Si tratta di mettere al bando “quelle limitazioni ed ingiustizie che rendono ogni vita umana, comunque concepita, impossibile”, non prescrivendo alcun modello di vita buona.
È la capacità di scegliere i progetti di vita, in tanto possibile in quanto legata all’acquisizione dei funzionamenti che delineano le condizioni di vivere dei soggetti (A. Sen).
Le capacità, infatti, sono un insieme di vettori di funzionamenti e riflettono la libertà degli individui di acquisire “lo star bene”, la dimensione dei soggetti agenti «è chiamata in causa dalla contrazione o dall’azzeramento delle capacità delle persone di definire, modellare e scegliere i loro progetti di vita».
I diritti umani disegnano il perimetro dell’agire pratico, ponendosi come requisiti dell’agire e come vincoli all’agire. Sono requisiti che, dando priorità ai bisogni basilari dell’esistenza, difendono l’individualità limitata e indigente della persona e consentono la creazione e la garanzia di ambiti individuali di decisione e di azione. Sono vincoli che limitano l’agire altrui richiedendo che individui e istituzioni agiscano con la dovuta considerazione ed il dovuto rispetto nei riguardi di ognuno.
La pratica dei diritti umani è, dunque, in continua evoluzione. Sorti come pretese del soggetto da contrapporre al potere politico, sociale ed economico, i diritti si vanno trasformando alla luce dell’attenzione per i fini in cui il soggetto trova la propria realizzazione. Questa evoluzione si lega al proliferare delle “generazioni dei diritti” (di libertà, politici, sociali, culturali, allo sviluppo, alla pace, a un ambiente protetto, a un patrimonio genetico non manipolato, ecc.).
Così, i diritti umani, che rimandano all’universale dell’essere umano (nella sua essenza, persona, individualità, senza distinzione alcuna di qualità, ruoli, caratteristiche), vedono una ridiscesa in ognuno dei modi concreti, degli ambiti di vita dell’umano, che assumono significatività ai fini della tutela. Si articola, pertanto, un rapporto tra dimensione universale, che aveva segnato il sorgere dei diritti, e dimensione particolare, legata agli esseri umani materiali, storici, differenziati, collocati.
Da questo punto di vista, va segnalato il loro essere, al contempo, universali e contestuali. Questa universalità riguarda le condizioni esistenziali che gli esseri umani condividono. Dovremmo parlare, in proposito, di un “universalismo degli stati della vita umana”, posto che si è eguali non a prescindere dalle situazioni e dai contesti di vita in cui ci si trova, ma proprio in ragione delle differenze.
Per concludere. Il regime globale dei diritti umani poggia su documenti giuridici fondamentali, ma di fatto il rispetto dei diritti è stato per lungo tempo affidato alla buona volontà dei singoli Stati nazionali. Oggi si vanno formando sistemi di controllo interstatali e regionali, aree culturali che si possono identificare in ordine d'incidenza nella regione europea, in quella inter-americana, in quella africana e in quella asiatica e del medio- oriente. Di conseguenza i diritti sono universali quanto alla definizione e invece particolari quanto all'applicazione.
Ciò detto non esiste forse un problema di applicazione, di vincolatività di questi diritti, eleganti, decisivi nell’esposizione ma confinati nell'aspetto programmatico senza incidere nell'aspetto precettivo e vincolante?
Illuminante la posizione di chi osservò che per i diritti umani è secondario definire il fondamento ultimo assoluto, mentre è decisivo che siano applicati, rispettati. “Mai definirli indipendentemente dal loro esserci di fatto” (N. Bobbio, Sul fondamento dei diritti dell’uomo, Einaudi, Torino, 1990).
Il problema di fondo, in altri termini è oggi non tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. Quindi il problema non è solo più solo di natura filosofica, ma politico e giuridico: il rispetto e la tutela dei diritti stilati e condivisi nel 1948. Per Bobbio la Dichiarazione ha riconosciuto un sistema di valori fino a quel momento solo enunciati. E questi valori “in quel momento storico sono generalmente condivisi”. Nasce una nuova consapevolezza comune in termini di appartenenza per ciascun individuo.
Oggi sono vincolanti ma non sanzionabili. Ed allora, in sintesi, quale destino hanno queste Dichiarazioni? Sono simboliche come disegno ideale o invece funzionali per essere applicati? Quale rispetto hanno? Qualche timido tentativo vi è stato (Corte Europea dei diritti dell'uomo, 1950 – Corte interamericana dei diritti universali 1969).
È un problema ancora più complesso in quei sistemi istituzionali che sono dotati di sanzione, ma non riescono ad applicarla. È il caso esemplare e scolastico diritto penale, sistema complesso ed articolato che ondeggia tra pene muscolari ma spesso infruttuose perché inapplicate, amplificando la minaccia simbolica a scapito del realismo dell'esecuzione. Si smarrisce l'obiettivo istituzionale che è quello della prevenzione, cioè di mostrare la realtà di chi sbaglia e di dissuadere la collettività nell'agire come lui.
“A scrivere sui diritti umani si prova un senso di imbarazzo, quasi di rimorso. Nel guardare l’umanità, la fame, i campi di rifugiati, le imbarcazioni senza asilo viene voglia di posare la penna. E tuttavia come posare la penna? E tuttavia come tacere quando sembra talvolta che la radice assoluta che dice ‘tu devi’ rischia di atrofizzarsi? Senza questa radice i diritti umani perdono di senso. Bisogna curarla, nutrirla, stimolarla con l’ausilio degli strumenti giuridici ispirati dalla Dichiarazione Universale” (J. Hersch, La dichiarazione dei diritti dell’uomo da un punto di vista filosofico, Bruno Mondadori, 2008).
Più prosaicamente è l’augurio di uno spirito libero e fiero, Ernesto Rossi, che definiva le discussioni e i proclami come le cure termali: gli effetti non si sentono subito, ma con il passare del tempo.